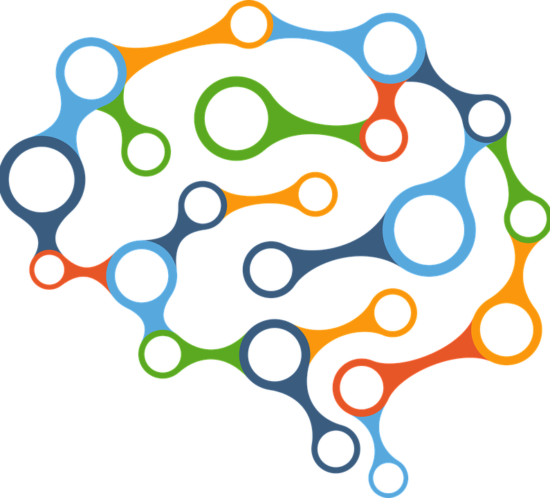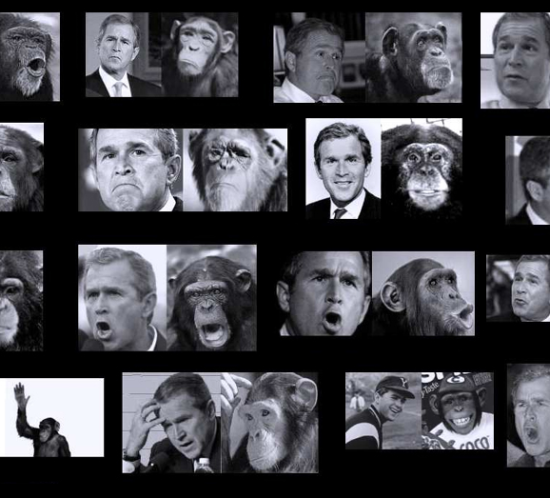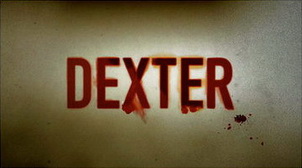I Nostri Reportage: 25th European Congress of Psychiatry
Citazione Consigliata: Tages Onlus (2017). I Nostri Reportage: 25th European Congress of Psychiatry [Blog Post]. Retrieved from: https://www.tagesonlus.org/2017/04/06/i-nostri-reportage-25th-european-congress-of-psychiatry/
Tra il 1°e il 4° aprile 2017 Firenze ha ospitato il XXV Congresso Europeo di Psichiatria. Il congresso è stato organizzato dalla European Psychiatric Association (EPA), ovvero la maggiore società scientifica europea di psichiatria che coinvolge numerosi membri individuali e oltre 40 associazioni scientifiche nazionali. Alla 25esima edizione erano iscritti quasi 1000 partecipanti con un programma estremamente variegato e ricco, al punto da annoverare ogni giorno circa 100 relatori tra simposi ed e-posters walk. Nel passare brevemente in rassegna quanto avvenuto, ci limiteremo pertanto a solo poche impressioni e ad alcune tra le relazioni più seguite e dibattute.
Durante il primo giorno di relazioni (successivo ad una giornata di pre-congress workshops) le sessioni con il maggior numero di relatori e partecipanti sono state sicuramente quelle relative ai disturbi bipolari (Bipolar Disorders – BD) e a quelli dello spettro schizofrenico. In particolare si sono passati in rassegna i più recenti studi legati all’insorgenza dei BD e al loro sviluppo evolutivo. Particolarmente seguite le relazioni di Ralph Kupka e Philippe Conus che hanno evidenziato come esordi precoci condizionino negativamente lo sviluppo della patologia. L’équipe di Conus ha inoltre riportato i risultati di uno studio volto a definire un cut-off significativo di età che possa aiutare a distinguere come la componente ereditaria predica l’insorgere del disturbo (figli di genitori con esordio antecedente i 21 anni sarebbero ad alto rischio). Al contempo BD ad insorgenza tardiva parrebbero correlarsi all’esposizione ad eventi traumatici mostrando quindi in tal caso una componente ambientale psicopatogena.
Di grande interesse anche il simposio su i sintomi negativi dello spettro schizofrenico che ha visto il coinvolgimento di due diversi Special Interest Group (SIG) dell’EPA: il SIG sulla schizofrenia e quello sugli studi di neuroimaging. L’obiettivo del simposio è stato infatti quello di mostrare le convergenze tra la concettualizzazione psichiatrica di tali sintomi discendente dalla tradizione fenomenologica e i più recenti studi di neuroimaging. Andrea Raballo ha sottolineato come vi sia una tendenza a sovrastimare i sintomi negativi nell’inquadramento del paziente e della sua patologia conducendo da un lato ad un rischio di diagnosi errata, dall’altro alla tendenza a non valutare il vissuto soggettivo della persone con effetti assai negativi nell’impostazione del piano terapeutico e riabilitativo. Il vissuto soggettivo è infatti fondamentale per comprendere la componente iper-riflessiva del paziente schizofrenico, ovvero la sua tendenza a focalizzare esclusivamente l’attenzione sulla dimensione intrapersonale escludendo quella oggettuale o ambientale. Come ha evidenziato infatti Armida Mucci la concettualizzazione dei sintomi negativi ha visto una significativa evoluzione sia in termini psicopatologici che psicometrici evindenziando due componenti: la cosiddetta avolition e la povertà nell’espressione emotiva. Gli studi fenomenologici e neurobiologici sembrano quindi evidenziare un assunto comune nelle neuroscienze cognitive: come ha più volte rimarcato Daniel Siegel il cervello umano è una macchina anticipatoria. Anche nella compresione della cognizione sociale del paziente schizofrenico la dimensione volitiva ed anticipatoria sono cruciali nell’inquadramento del vissuto soggettivo e delle problematiche psicopatologiche, nonchè nell’impostazione di trattamenti personalizzati.
Tra le molte tematiche presenti nella 3 giorni congressuali, alcune di lunga tradizione (come il dibattito sull’utilità del costrutto di schizofrenia), altre di urgente attualità (come lo sviluppo di servizi in grado di accogliere stranieri e migranti), una ha indubbiamente mostrato notevole vitalità. Ogni qualvolta ci siamo recati alle sessioni dedicate alla neurobiologia e all’epigenetica, molti erano gli uditori in piedi o seduti a terra. Gli studi delle équipe di Thomas Frodl e Rupert Lanzenberger hanno ad esempio evidenziato come la componente epigenetica dei disturbi psichiatrici sia uno dei campi di maggior interesse e di maggior sviluppo. In particolare le meta-analisisi sul ruolo svolto da i recettori 5-HT1a nella depressione e nell’ansia mostrano evidenze assai rilevanti ed incontrovertibili.
E questo ambito risulta tanto più rilevante, quanto al centro di un dibattito non semplicemente scientifico, ma più genericamente culturale e politico sul ruolo della moderna psichiatria. La lettura magistrale di apertura della prima giornata e molte delle discussioni udite, in particolare durante i simposi su temi quali l’epigenetica, hanno evidenziato come la domanda letta in veri editoriali scientifici sia ancora aperta: la psichiatria è in crisi?
Nel formulare la sua personale risposta Mario Maj ha da un lato rimarcato un sentore comune nella psichiatria (e nella psicologia) di contrapposizione e rincorsa alla neurobiologia e dall’altro ha evidenziato la necessità di sviluppare nuovi e complessi sistemi di inquadramento diagnostico. A prescindere dalle specifiche posizioni di singoli autori o gruppi ricerca il perdurare di una percezione di scollamento tra sapere fenomenologico e sapere biologico può solo nuocere al destino della salute mentale.
Da un punto di vista culturale è forse necessaria un’ulteriore assimilazione di concetti propri della neurobiologia e dell’evoluzionismo che delineano una multifattorialità che certo non sminuisce la componente descrittiva e relazionale della psichiatria. Da un punto di vista politico è auspicabile favorire non solo in termini formativi, ma sopratutto in termini decisionali la diffusione di una modalità multidisciplinare e condivisa nel definire ed attuare i piani terapeutici. Solo separando la dimensione culturale da quella politica possiamo operare pragmaticamente nei confronti di due altre dimensioni: quella economica e quella scientifica. L’efficentissimo principio anglosassone “whatever works” riteniamo debba essere applicato nel perseguire un modello di psichiatria sostenibile ed efficace agli occhi di tutti gli stakeholder.
Concludiamo riportando come anche Tages Onlus abbia partecipato con due contributi: (i) uno studio di fattibilità su un intervento integrato e modulare per pazienti con dipendeza da cocaina; (ii) uno studio teorico sull’utilizzo della teoria dei sistemi complessi nello sviluppo della moderna psicoterapia cognitivo-comportamentale.
Lo Staff di Tages Onlus